Porre fine al “grande gioco” per risolvere la guerra del Levante
- Dettagli
- Visite: 4927
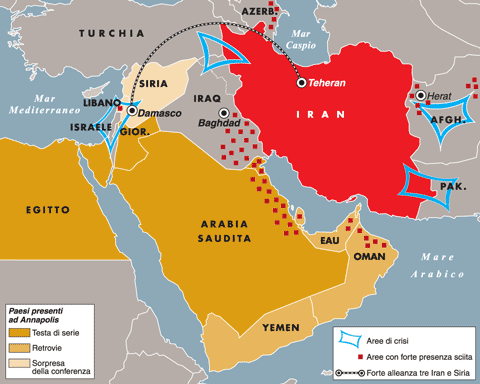 Analisi, gennaio 2016 - Proponiamo, tratto dall'ultimo numero delal rivista (6/15) "Italiani Europei", un interessante articolo del professore Vittorio Emanuele Parsi (a sinistra mappa del Medio Oriente)
Analisi, gennaio 2016 - Proponiamo, tratto dall'ultimo numero delal rivista (6/15) "Italiani Europei", un interessante articolo del professore Vittorio Emanuele Parsi (a sinistra mappa del Medio Oriente)
Italianieuropei, 6/15
Porre fine al “grande gioco” per risolvere la guerra del Levante
Vittorio Emanuele Parsi (16 dicembre 2015)
L’universalizzazione dell’ostracismo contro l’Iran e la crescita dell’influenza regionale sia di Teheran che di Riyad hanno esacerbato in questi anni la rivalità originaria tra Arabia Saudita e Repubblica Islamica: un conflitto innanzitutto ideologico, e poi strategico ed economico. Ma non si può pensare ad alcuna stabilità nella regione escludendo l’Iran e le sue legittime ambizioni di sicurezza.
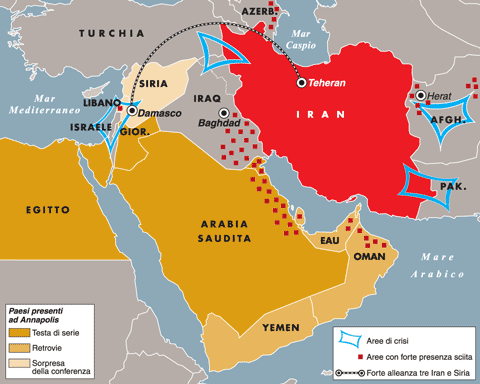
E'la rivalità tra Arabia Saudita e Iran per l’egemonia sul Levante ad alimentare la guerra civile siriana e ad averne accelerato la deriva settaria, trasformando la rivolta contro il regime autoritario e cleptocratico di Assad in una guerra di religione tra sciiti e sunniti. La lotta tra la monarchia conservatrice saudita e la Repubblica Islamica iraniana è, del resto, solo l’ultimo dei tentativi egemonici che hanno interessato la regione, finora tutti frustrati, in gran parte, proprio grazie all’attivismo saudita.
Il primo, il più imponente, ebbe come protagonista l’Egitto di Nasser, nel decennio a cavallo tra gli anni Cinquanta e gli anni Sessanta: si arrivò, allora, alla costituzione della Repubblica Araba Unita tra Egitto e Siria, mentre nello Yemen le truppe del Cairo prestavano manforte, fino al 1967, alla rivoluzione divampata nei confronti dell’imamato appoggiato dai sauditi. Proprio la sconfitta patita a opera degli israeliani avrebbe posto fine alle ambizioni del rais egiziano. Negli anni Ottanta sarebbe stata la volta dell’Iraq di Saddam Hussein, la cui guerra d’aggressione contro il neonato Iran khomeinista, finanziata e spalleggiata dalle petro-monarchie arabe, gli aveva fatto credere di essersi guadagnato credenziali sufficienti per candidarsi a leader del Levante e del Golfo. Nel 1990, l’errore di calcolo a proposito del Kuwait sarebbe costato caro al dittatore di Baghdad, e avrebbe condannato il suo regime e il suo popolo a una lunga agonia: terminata per il primo nel 2003, ancora in corso per il secondo. Quello cui stiamo assistendo è, quindi, il terzo tentativo egemonico, questa volta operato contemporaneamente da due attori che nutrono una rivalità quasi quarantennale, e che però si è decisamente accentuata negli ultimi anni.
La ruggine tra sauditi e iraniani risale al 1978, alle origini della rivoluzione islamica ispirata da Khomeini, e ha proprio a che vedere con l’utilizzo speculare dell’Islam come fattore di legittimazione del potere e del regime che lo incarna. Per l’Iran la declinazione politica dell’Islam ha un connotato rivoluzionario (il riscatto degli oppressi e il cambiamento radicale del ceto politico), per l’Arabia Saudita l’Islam è impiegato come fattore di conservazione dello status quo, ovvero delle posizioni di potere e ricchezza acquisite dalla famiglia allargata degli al-Saud su gran parte della penisola.
Non si tratta, quindi, di una opposizione tra Islam sciita e Islam sunnita, tant’è vero che ai tempi del regime dello scià i rapporti tra i due paesi non erano affatto tesi. Ma, evidentemente, la contrapposizione tra sciiti e sunniti è quella in cui si inserisce questa rivalità ideologica e che per molti versi la rinfocola. Soprattutto da parte saudita, per la verità, la polemica settaria, anti-sciita, è alimentata all’interno di una strategia coerente, volta a diluire l’eccezionalità del posizionamento ultraconservatore della monarchia saudita attraverso l’attivo proselitismo della sua versione dell’Islam (il wahabismo) nel mondo sunnita. Proprio la manipolazione della millenaria frattura tra sciiti e sunniti ha contribuito a infiammare la temperatura politica di una regione, il Levante (ma anche il Golfo), dove quasi tutti gli Stati presentano una composizione mista.
Se quella tra il regno dell’Arabia Saudita e la Repubblica Islamica dell’Iran è una rivalità originaria, dovremmo, perciò, chiederci come mai proprio in questi anni si sia esacerbata. La risposta, a mio avviso, si trova in due fattori: l’universalizzazione dell’ostracismo nei confronti dell’Iran e la crescita contemporanea dell’influenza regionale sia di Teheran sia di Riyad. L’universalizzazione dell’ostracismo iraniano risale alla scoperta negli anni Novanta di un programma nucleare segreto sviluppato dalle autorità iraniane. Com’è noto, il fatto che tale programma fosse basato su una tecnologia duale (in grado di consentire impieghi civili e militari dell’energia atomica), unito alla scarsissima collaborazione mostrata da Teheran nei confronti dell’Agenzia internazionale per l’energia atomica (AEIA), ha portato progressivamente all’adozione di sanzioni sempre più dure nei confronti dell’Iran da parte dell’intera comunità internazionale. Parliamo di un ostracismo universale perché, per definizione, ogni violazione del Protocollo aggiuntivo del Trattato di non proliferazione nucleare riguarda la stabilità del sistema internazionale nel suo complesso. Se l’Iran è stato gravemente danneggiato da sanzioni pesantissime e applicate con un’interpretazione assai più estensiva della media, l’Arabia Saudita si è trovata a godere di un oggettivo vantaggio. La caduta del regime dello scià l’aveva già candidata a possibile partner della superpotenza americana per la stabilizzazione del Golfo Persico. L’ostracismo universale dell’Iran faceva ora della vigilanza sull’operato della Repubblica Islamica una questione “mondiale” e non più una mera preoccupazione saudita, riconducibile a una rivalità regionale di carattere geopolitico. È appena il caso di segnalare che la violenta polemica nei confronti di Israele, unita al sostegno al partito-milizia libanese di Hezbollah, rendeva l’Iran ancora più isolato soprattutto nei confronti del mondo occidentale. La seconda ragione di esasperazione della rivalità saudita-iraniana, come dicevamo, risiede nella rapida e congiunta crescita dell’influenza regionale dei due regimi. A favorire quella iraniana erano state le guerre: nessuna delle quali combattuta dall’Iran ma, paradossalmente, intraprese dai suoi principali avversari. Nel 2001 la sconfitta a opera degli Stati Uniti del regime talebano, ostile agli ayatollah e finanziato e protetto da sauditi e pachistani, aveva, infatti, messo in sicurezza il confine orientale iraniano. Nel 2003 era stata la volta di Saddam Hussein a essere tolto di mezzo da parte delle truppe di Washington. Il risultato era la sostituzione di un regime a dominanza sunnita con uno alleato a predominio sciita (e in parte curdo). Nel luglio 2006, poi, la “guerra dei 33 giorni”, la terza invasione israeliana del Libano, consentiva a un Hezbollah in grande difficoltà interna (dopo l’omicidio di Rafik Hariri, il 14 febbraio 2005, e il successivo ritiro siriano dal paese dei cedri, con la costituzione di un Tribunale internazionale per il Libano e la formazione di un governo molto filoccidentale), di riconquistare il centro della scena sulle ali della vittoria politico-militare conseguita nei confronti dell’esercito di Tel Aviv.
Per parte saudita, oltre ai vantaggi legati alla sterilizzazione dell’Iran a seguito delle sanzioni, era la caduta del regime di Saddam Hussein a eliminare uno scomodo protagonista, mentre le conseguenze negative della nascita di un regime sciita a Baghdad erano neutralizzate attraverso il finanziamento sistematico all’insorgenza sunnita e alle formazioni dalle quali sarebbero sorte prima al Qaeda in Iraq e poi l’ISIS. Era, però, un terzo, inaspettato fattore, quello che avrebbe spianato la strada alle più incredibili ambizioni della casa degli al-Saud, ovvero l’esito delle primavere arabe. Queste ultime non potevano certo piacere ai governanti sauditi, che, infatti, non solo forniranno asilo al fuggitivo Ben Ali (il deposto dittatore tunisino), ma sosterranno fino all’ultimo Mubarak, provando anche a sostituirsi agli Stati Uniti nel ruolo di finanziatore del suo regime, provocando l’ira furibonda di Washington. Proprio il decorso iniziale della rivoluzione più importante, quella egiziana, con il successo della Fratellanza Musulmana e l’elezione di Mohamed Morsi alla presidenza, sembrava dover rappresentare un fiasco politico e una minaccia ideologica per Riyad. In realtà, l’insipienza, la corruzione e l’ambiguità dell’amministrazione dei Fratelli Musulmani creavano le premesse per un pronunciamento militare contro Morsi, guidato dal generale al-Sisi, successivamente eletto alla presidenza. Da questo momento in poi, l’Egitto, questa volta con la benedizione di Washington, sarebbe stato sostenuto innanzitutto finanziariamente dai sauditi, che avrebbero trasformato l’acerrimo rivale dei tempi di Nasser in un fido cliente, come paradossalmente l’appoggio egiziano alla guerra anti Huthi intrapresa in Yemen dall’Arabia Saudita avrebbe dimostrato. Successivamente, l’ondata di rivolta avrebbe colpito la Libia e la Siria: e se nel primo caso sarebbe stato l’intervento occidentale a trazione anglo-francese a gettare il paese nel caos, nel secondo sarebbe stato proprio il crescente coinvolgimento di Arabia Saudita e Iran a trasformare una rivoluzione contro un regime autocratico e corrotto in una guerra civile, campo di battaglia per i due aspiranti egemoni regionali.
Così, se il primo decennio del nuovo millennio si chiudeva con un Iran in vantaggio, capace di disegnare quell’arco sciita che dalle coste del Golfo, attraverso Iraq, Siria e Libano, arrivava al Mediterraneo, quello successivo vedeva il recupero dell’Arabia Saudita, ormai liberata da ogni potenziale sfidante arabo e in grado di modificare la sua strategia tradizionale. Riyad poteva non limitarsi più ad affermare la propria egemonia nella penisola araba e a contrastare i ricorrenti tentativi egemonici degli altri (egiziani, iracheni o iraniani che fossero). Ora poteva aspirare alla propria egemonia sul Golfo e sul Levante, affermandola attraverso la distruzione del regime di Assad e la destabilizzazione sistematica dell’Iraq. Ed è precisamente su questo sfondo che emerge l’ISIS, che conduce non tanto una guerra per procura saudita in Siria e Iraq, ma i cui obiettivi coincidono (per la parte relativa all’abbattimento del regime siriano e alla destabilizzazione di quello iracheno) con gli obiettivi strategici dei sauditi. D’altronde, il brodo di coltura che alimenta il suo islamismo iper-puritano e l’odio per gli sciiti è quello nutrito da decenni di predicazione salafita e la parabola compiuta dal movimento nei suoi rapporti con l’Arabia Saudita non è diversa da quella conosciuta da al Qaeda.
Quello che, però, riapre una partita tra Riyad e Teheran, che sembrava ormai compromessa per gli iraniani, è la stipulazione del Joint Comprehensive Plan of Action (JCPOA) tra i 5+1 (i cinque membri permanenti del Consiglio di sicurezza più la Germania) e l’Iran sul dossier nucleare. Ancorché il documento firmato a Vienna il 14 luglio preveda un’implementazione lunga e laboriosa, sottoposta a verifiche tecniche (la prima entro il prossimo gennaio da parte dell’AIEA) e strettoie politiche (che orientamento avrà a riguardo la nuova Amministrazione americana che si insedierà a febbraio 2017?), l’accordo consentirà nei prossimi anni all’Iran di tornare a essere una tessera fondamentale del puzzle mediorientale. Non a caso, l’ostilità rispetto all’accordo ha visto emergere criticità nel rapporto peraltro inossidabile tra Washington e Riyad e tra Washington e Tel Aviv. Mentre ha prodotto una convergenza anche rispetto alla guerra civile in Siria tra israeliani e sauditi. Per entrambi questi ultimi, infatti, la fine della condizione di “pariah” dell’Iran rappresenta una grossa preoccupazione e il rischio che ciò determini un’ulteriore ascesa della Repubblica Islamica costituisce un fatto inaccettabile. Dopo aver cercato in tutti i modi di far naufragare il JCPOA (la cui firma dovrebbe implicare una minaccia esistenziale per Israele, nonostante esso sia la sola potenza nucleare della regione, con un numero di testate stimato superiore a quello di Francia e Inghilterra), l’offensiva è passata sulla “natura inaffidabile” del contraente iraniano.
Fino a ora le potenze firmatarie occidentali hanno resistito a tutti i tentativi di svuotare i contenuti dell’accordo attraverso la delegittimazione della Repubblica Islamica e, questo, nonostante la natura illiberale e repressiva del regime degli ayatollah offra fin troppi argomenti a operazioni del genere. Ma è l’intervento diretto russo nella guerra civile siriana che potrebbe complicare il quadro. Putin si è dimostrato il più lesto nel capitalizzare il nuovo status dell’Iran. In questo ha battuto sul tempo il disegno, neppure troppo dissimulato, dell’Amministrazione Obama: favorire un’evoluzione dall’interno del regime proprio grazie al progressivo rilassamento delle sanzioni e al miglioramento delle condizioni di vita della popolazione, delle quali il presidente Hassan Rouhani potesse rivendicare il merito politico. Sul teatro operativo siriano, d’altronde, Mosca condivideva con Teheran non solo i nemici (ISIS e Jabhat al-Nusra), ma anche gli amici (il regime di Assad). Come la nuova Amministrazione americana saprà, vorrà e potrà porsi rispetto a un Iran “troppo vicino” a Mosca è tutto da vedere.
Nel frattempo, purtroppo, la guerra civile siriana rischia di tracimare nel vicino Libano, destabilizzandone il sempre più precario equilibrio. L’attentato del 12 novembre nel quartiere di Bourj al Barajneh, periferia sciita di Beirut, costato 43 morti e 239 feriti, è solo il più tragico avviso della nuova escalation del conflitto siriano. Un simile gesto criminale non potrà che aumentare la determinazione iraniana a sostenere i propri alleati in Libano e in Siria, ovviamente provocando un atteggiamento analogo da parte saudita. L’attentato, rivendicato dall’ISIS, è stato presentato come una rappresaglia per il crescente (e decisivo per le sorti del regime siriano) intervento di Hezbollah in Siria ed è avvenuto a pochi giorni dall’inizio della seconda fase dei colloqui di Vienna, dove per la prima volta Teheran è ammessa a partecipare.
Gli attentati di Parigi nella notte del 13 novembre hanno poi dimostrato la capacità dell’ISIS di portare la guerra nel cuore stesso dell’Europa, colpendo uno dei pochi paesi occidentali che si batte con determinazione contro i terroristi senza con ciò fare sconti al regime di Assad, e fornisce una ragione in più all’urgenza di porre fine al conflitto che nel Levante ha tenuto a balia lo sviluppo dell’organizzazione di al-Baghdadi.
Nella confusione che regna sovrana intorno alle possibili vie di uscita dalla crisi siriana, tra veti incrociati, manovre inconfessabili e reciproci sospetti, è molto difficile che il nuovo “grande gioco” della rivalità tra sauditi e iraniani possa trovare autonomamente una ricomposizione nel breve periodo. La sola premessa da cui mi pare occorra partire è che nessuna stabilità è pensabile escludendo l’Iran e le sue ambizioni di sicurezza, legittime quanto quelle di chiunque altro nella regione. È ancora poco per arrivare a “disarmare” un conflitto innanzitutto ideologico, e poi strategico ed economico, tra Teheran e Riyad, ma è un passo di realismo politico necessario e non più procrastinabile. D’altronde, occorre essere chiaramente consapevoli che se non si costringeranno Riyad e Teheran ad abbassare il livello del loro scontro, la guerra che insanguina il Levante non conoscerà fine e l’ISIS continuerà a fare proselitismo e vittime.


.png)






